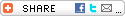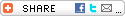(Clicca sulle immagini per allargarle - Foto donate dalla Fondazione Arena di Verona.) (Clicca sulle immagini per allargarle - Foto donate dalla Fondazione Arena di Verona.)
 Lo spettacolo messo in scena al Filarmonico di Verona da Fabio Sparvoli non rende sicuramente onore alla nobile partitura, anzi tende a sminuirla.
Lo spettacolo messo in scena al Filarmonico di Verona da Fabio Sparvoli non rende sicuramente onore alla nobile partitura, anzi tende a sminuirla.
Tanto nei protagonisti, quanto nel coro la gestualità è ridotta ai minimi termini, a tratti quasi assente, e questa lacuna è fastidiosamente notevole. Inoltre la vicenda parla quasi esclusivamente di sentimenti, ma non uno sguardo, non un movimento, cercano di metterli in risalto e ciò porta a notare ancor di più la mancanza di azione.
Il vuoto drammaturgico dell'opera è giustamente riempito dalle coreografie ideate da Maria Grazia Garolfi, ma che sfortunatamente non sono adatte né alla musica, né all'ambientazione storica, apparendo avulse da tutto l'insieme. Addirittura nel finale i danzatori, abbigliati alla stregua di avatar e divinità Indu, si prodigano in un ballo che ha più il sapore maori piuttosto che induista.
Anche le scene di Giorgio Ricchelli non rendono giustizia all'opera, troppo semplici in primo atto – un solo tronco d'albero secco poggiato sul pavimento-spiaggia – quasi da sembrare una versione semiscenica. Si arricchiscono lentamente col procedere dell'opera, ma paiono ricordare più Angkor in Cambogia piuttosto che Anuradhapura e Polonnaruwa in Sri Lanka.

I costumi di Alessandra Torella sono chiaramente sbagliati: tutto lo spettacolo sembra voler dare un'impronta realistica, ma nessun personaggio, né alcun corista, è certamente abbigliato nella corretta maniera tamil o singalese. Gli uomini indossano casacche e pantaloni che poco somigliano ai kurta o ai salwar kamiz, mentre le donne portano magliette corte, gonne e lunghi veli, molto lontani da quelli che dovrebbero essere sari o salwar kamiz e dupatta.
Nemmeno le luci di Vinicio Cheli sanno creare la giusta suggestione.
La direzione di Frédéric Chaslin è nella norma, senza infamia e senza lode, e passa abbastanza inosservata.
L'esibizione del Coro dell'Arena di Verona diretto da Andrea Cristofolini è buona nel canto, ma davvero ridotta ai minimi termini per ciò che riguarda l'interpretazione.
L'idea che uno spettatore si può fare nell'assistere a questa rappresentazione è quella di uno spettacolo approssimativo e messo in piedi in pochi giorni e con poche prove.
 Nino Machaidze riesce a portare a casa la pelle nel ruolo di Léïla e ottiene buoni consensi dal pubblico, ma non è propriamente limpida, né corretta nell'esecuzione. Innanzitutto la voce mostra segni di usura e ciò dovrebbe accadere dopo almeno venti o trenta anni di carriera, quaranta per alcune professioniste. Il giovane soprano georgiano è in difficoltà negli acuti, peggiora ulteriormente nei sovracuti, mentre il registro grave appare molto vuoto.
Nino Machaidze riesce a portare a casa la pelle nel ruolo di Léïla e ottiene buoni consensi dal pubblico, ma non è propriamente limpida, né corretta nell'esecuzione. Innanzitutto la voce mostra segni di usura e ciò dovrebbe accadere dopo almeno venti o trenta anni di carriera, quaranta per alcune professioniste. Il giovane soprano georgiano è in difficoltà negli acuti, peggiora ulteriormente nei sovracuti, mentre il registro grave appare molto vuoto.
Antonino Siragusa dà prova della propria professionalità, ma da un tenore del suo calibro e vocalità ci si aspettava di più. La linea di canto è ottima, gli acuti sempre saldi e limpidi, ma le note basse sono molto deboli e le mezzo voci e i filati, che tutti attendevano in "Je crois entendre encore", non sono arrivati.
Luca Grassi parte in sordina, con voce molto opaca e spesso coperta dalla compagine orchestrale. Si riprende fortunatamente in terzo atto ed esegue l'aria "L'orage s'est calmé… O Nadir, tendre amis de mon jeune âge" e il successivo duetto in maniera corretta.
Paolo Pecchioli è un efficace Nourabad, purtroppo costretto in un costume più adatto ad un Maharaja che ad un sacerdote Indu.
|