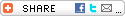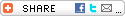Dopo un tuffo nella tradizione belcantistica con L'Elisir d'amore
e Lucia di Lammermoor, il Maggio Musicale Fiorentino
propone il capolavoro di Ruggero Leoncavallo I Pagliacci, nel celebre
allestimento curato da Franco Zeffirelli.
Solitamente introdotta da balletti o affiancata a Cavalleria Rusticana,
altro manifesto del verismo lirico, l'opera viene in questo caso anticipata da
alcune fra le più belle pagine sinfoniche di Mascagni e Puccini:
sotto la direzione di Patrick Fournillier, l'organico del Maggio esegue
brani da L'Amico Fritz, Guglielmo Ratcliff, Cavalleria e Manon, saggi di
quel “poema sinfonico scenico” teorizzato da Ferdinando Fontana, in cui
l'orchestra diviene elemento narrativo e descrittivo sempre più emancipato dal
primato del canto.
La complessità di Pagliacci non renderebbe necessaria alcuna integrazione: a
fronte di una trama esile e relativamente breve, l'ambigua psicologia dei
protagonisti e il gioco metateatrale richiedono un'intensa partecipazione da
parte dello spettatore, chiamato a interpretare la natura delle pulsioni da cui
il dramma ha origine.
 Le intenzioni dell'autore sono chiarite fin da subito dalla voce del
commediante Tonio (il baritono Seng-Hyoun Ko) sulla ribalta, a
sipario chiuso, in veste di Prologo: in sgargiante tenuta da clown, faccia
bianca, parrucca colorata e abito con lustrini, il deforme personaggio ricorda
che non ci sarà finzione, ma vera tragedia, scandagliata nella sua completezza
di atti, reazioni ed emozioni alla maniera del romanzo naturalista. Protagonista
non è, quindi, l'illusione portata in scena dall'attore, ma la nuda verità
dell'uomo, spietatamente rappresentato nelle proprie aspirazioni e bassezze. Il
cantante coreano delinea un personaggio più penoso che crudele, imprigionato nel
dolore, fisico e psicologico, di un corpo sgraziato; il timbro è pieno e caldo,
l'intonazione precisa, sebbene l'esecuzione tradisca incertezze nell'accordo con
la direzione orchestrale di Fourniller.
Le intenzioni dell'autore sono chiarite fin da subito dalla voce del
commediante Tonio (il baritono Seng-Hyoun Ko) sulla ribalta, a
sipario chiuso, in veste di Prologo: in sgargiante tenuta da clown, faccia
bianca, parrucca colorata e abito con lustrini, il deforme personaggio ricorda
che non ci sarà finzione, ma vera tragedia, scandagliata nella sua completezza
di atti, reazioni ed emozioni alla maniera del romanzo naturalista. Protagonista
non è, quindi, l'illusione portata in scena dall'attore, ma la nuda verità
dell'uomo, spietatamente rappresentato nelle proprie aspirazioni e bassezze. Il
cantante coreano delinea un personaggio più penoso che crudele, imprigionato nel
dolore, fisico e psicologico, di un corpo sgraziato; il timbro è pieno e caldo,
l'intonazione precisa, sebbene l'esecuzione tradisca incertezze nell'accordo con
la direzione orchestrale di Fourniller.
Per la prima volta nella sua carriera di regista e scenografo teatrale,
Zeffirelli decide di allontanarsi dalle indicazioni del libretto e di
attualizzare la vicenda, ambientandola in un degradato sobborgo: sullo sfondo,
la grigia facciata di un edifico in cui si aprono scorci di tristi abitazioni e
negozi, dominati da televisori e luci a neon; al centro, così come
sull'impalcatura che ricopre il caseggiato, un vorticoso brulichio di persone,
adulti e bambini, piccoli delinquenti e prostitute, tutti colti nella
naturalezza dell'agire quotidiano. Biciclette, una roulotte e un'automobile
muovono ancor più la scena, in una frenesia di azioni scomposte e disordinate.
 Come raramente accade, si coglie l'impaccio del Coro del Maggio, a
disagio in gestualità e spostamenti, disorientato da un'atmosfera inusuale per
la lirica. Il palco è fin troppo carico di cose e persone, il voluto caos manca
di quell'ordine interno che è canone teatrale necessario a mantenere leggibile
il fulcro dell'azione: l'ingresso della compagnia di attori perde forza, le
divertenti acrobazie dei clown non trovano spazio adeguato, mentre la
riflessione di Canio riguardo alle sostanziali differenze fra teatro e
realtà viene fagocitata dal disordine scenico creatosi. In look da guappo (i
costumi sono di Raimonda Gaetani), il capocomico è interpretato
dall'energico Salvatore Licitra: complessivamente preciso
nell'esecuzione, il tenore restituisce i caratteri di un uomo vittima della
propria violenza e dell'incapacità di gestire il dolore. Come raramente accade, si coglie l'impaccio del Coro del Maggio, a
disagio in gestualità e spostamenti, disorientato da un'atmosfera inusuale per
la lirica. Il palco è fin troppo carico di cose e persone, il voluto caos manca
di quell'ordine interno che è canone teatrale necessario a mantenere leggibile
il fulcro dell'azione: l'ingresso della compagnia di attori perde forza, le
divertenti acrobazie dei clown non trovano spazio adeguato, mentre la
riflessione di Canio riguardo alle sostanziali differenze fra teatro e
realtà viene fagocitata dal disordine scenico creatosi. In look da guappo (i
costumi sono di Raimonda Gaetani), il capocomico è interpretato
dall'energico Salvatore Licitra: complessivamente preciso
nell'esecuzione, il tenore restituisce i caratteri di un uomo vittima della
propria violenza e dell'incapacità di gestire il dolore.
Le necessità poetiche espresse nel Prologo trovano giusta espressione quando,
non senza sollievo, la scena si spopola e lascia spazio a Nedda, la
sempre elegante Amarilli Nizza, persa nel proprio sogno di una vita
diversa. Ammaliante tanto in costume da attrice quanto in dimessa tenuta
domestica, la sua interpretazione colpisce per la consueta dolcezza delle
movenze e per il fascino del timbro particolarmente corposo, disinvolto in
potenza e delicatezza. Momenti di forte intensità soprattutto nel duetto con
Silvio, interpretato dal baritono Luca Salsi, di significativa
presenza scenica e sicura esibizione canora.
 Nel secondo atto il fondo scenico si riveste di giganti teloni colorati
raffiguranti volti di clown sorridenti; a sinistra, lo sfavillante palco in cui
andrà in scena la commedia, al centro le sedie in cui si dispone il chiassoso
pubblico. Tra giochi di luce, pareti girevoli, frizzi e lazzi d'ogni tipo
(difficile immaginare che la modesta compagnia di Canio possa usufruire
di tutti questi effetti speciali), inizia la vicenda di Pagliaccio, alle
prese con il tradimento di Colombina; simpatica e coinvolgente la
presenza del tenore Mark Milhofer, nei panni di Peppe/Arlecchino,
vivace nell'interpretazione seppur vocalmente debole. In un'altalena fra
spiritosa finzione, in cui si respirano atmosfere musicali tratte da Rossini e
Donizetti, e tragica realtà, si arriva alla conclusione della vicenda: anche in
questo caso, l'epilogo è stemperato dall'affollamento indisciplinato sul palco,
con conseguente allentamento della tensione drammatica. Nel secondo atto il fondo scenico si riveste di giganti teloni colorati
raffiguranti volti di clown sorridenti; a sinistra, lo sfavillante palco in cui
andrà in scena la commedia, al centro le sedie in cui si dispone il chiassoso
pubblico. Tra giochi di luce, pareti girevoli, frizzi e lazzi d'ogni tipo
(difficile immaginare che la modesta compagnia di Canio possa usufruire
di tutti questi effetti speciali), inizia la vicenda di Pagliaccio, alle
prese con il tradimento di Colombina; simpatica e coinvolgente la
presenza del tenore Mark Milhofer, nei panni di Peppe/Arlecchino,
vivace nell'interpretazione seppur vocalmente debole. In un'altalena fra
spiritosa finzione, in cui si respirano atmosfere musicali tratte da Rossini e
Donizetti, e tragica realtà, si arriva alla conclusione della vicenda: anche in
questo caso, l'epilogo è stemperato dall'affollamento indisciplinato sul palco,
con conseguente allentamento della tensione drammatica.
Sulla scia della tradizione iniziata da Fernando de Lucia ed Enrico Caruso
(primo disco d'oro della storia grazie a Pagliacci), l'ultima battuta "La
commedia è finita" è affidata a Canio: viene quindi a mancare quella
fondamentale coerenza drammaturgica che vede in Tonio il motore della
vicenda, dall'espressione delle necessità poetiche nel Prologo, passando dai
“tristi frutti dell'odio” fino alla cruda conclusione da lui sancita.
Applausi contenuti per l'uscita degli artisti, di certo penalizzati
dall'esuberanza di una scenografia che, seppur spettacolare, si rivela inutile
se non controproducente a un dramma che trova nella complessa psicologia dei
personaggi tutto ciò di cui ha bisogno per essere espresso al meglio.
 |