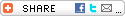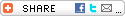Il Festival Verdi 2018 è l'edizione delle conferme, dalla
rinnovata buona qualità delle produzioni all'attenzione alla ricerca; una
rassegna che, dopo anni di tentennamenti, sta diventando un vero Festival.
Di indubbio interesse - artistico, culturale, musicale, storico, ma anche
semplicemente di curiosità melomaniacale e turistica - è l'attenzione per il
Verdi francese, prima con l'edizione critica di Jérusalem, ora
con quella di Le Trouvère.
In tal senso per il prossimo anno è prevista una battuta di arresto - già
annunciati sono i titoli de I due Foscari, Luisa Miller, Aida e Nabucco
- ma si spera che tale filone possa essere proseguito nel futuro.
La versione francese de Il trovatore possiede un legame molto particolare con
Parma, poiché fu l'opera inaugurale della prima edizione dell'allora Verdi
Festival 90 - poi subito naufragato - già all'epoca eseguita nella revisione a
cura di David Lawton per l'edizione critica. Non si tratta di
una mera traduzione, bensì di una rielaborazione - fatta per mano del Cigno di
Busseto - di otto dei quattordici numeri che compongono l'intera partitura, per
meglio adattare la musica al gusto parigino dell'epoca.
Ci si trova dunque di fronte ad un melodramma un poco più elegante e
leggermente meno acceso, sapientemente espresso dalla bacchetta di
Roberto Abbado - neo direttore musicale del Festival - che descrive con
raffinatezza il rinnovato stile dell'orchestrazione francese alla guida degli
eccellenti complessi artistici del Teatro Comunale di Bologna.
Ottima anche la prova del Coro preparato da Andrea Faidutti.
Ma la vera parte del leone la fa lo spettacolo visionario di Robert
Wilson che inserisce, nello spazio del tempo musicale, luci e movimenti
che non fanno altro che generare interrogativi. “Il mio non è un teatro di
messaggi. È un teatro di domande” ha affermato il celebre artista
statunitense ed è una sensazione sinceramente appagante poter assistere ad una
rappresentazione che incuriosisce senza rinchiudersi in un ambito ristretto di
risposte dettate da una vecchia mentalità tradizionalista. I simboli, le figure,
le metafore sono molteplici, ma non vogliono dare opinioni o visioni, bensì
creare quesiti e indurre all'osservazione, partendo dal presupposto che, seppur
la storia sia una, attraverso la musica la sua interpretazione può esserne molto
discosta.
Ne risulta dunque uno spettacolo elegante, accurato, studiato nei
minimi particolari, che affiancato alla pregevole lettura di Abbado può essere
sinceramente considerato un capolavoro artistico e come tale purtroppo soggetto
alla contestazione e all'incomprensione.
Un passo in avanti, per mantenere il medesimo livello qualitativo delle
produzioni, andrebbe compiuto anche in termini vocali, poiché il Festival
dovrebbe diventare anche il punto di riferimento dell'interpretazione verdiana.
Giuseppe Gipali è un Manrique discreto, canta correttamente senza intoppi né
sbavature, anche se non arriva mai a brillare come ci si aspetterebbe dal
protagonista.
Roberta Mantegna è una Léonore sicura nell'interpretazione e nella zona
centrale, ma continua a possedere qualche problemino negli acuti più estremi che
deve assolutamente risolvere prima che si creino danni permanenti.
Nino
Surguladze è una Azucena elegante e raffinata, morbida e omogenea, dalla voce
vellutata sempre piegata ai voleri dell'interpretazione.
Franco Vassallo è un
Comte de Luna ben saldo, dalla vocalità smaltata e dotato di un ottimo
fraseggio.
Marco Spotti è un Fernand inamovibile, la dura roccia di tutto lo
spettacolo, eccellente nella sua aria di sortita.
Completano il cast Tonia
Langella nei panni di Inès, Luca Casalin in quelli di
Ruiz e del messaggero,
Nicolò Donini in quelli del vecchio zigaro.
|