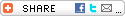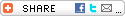Andrea De Rosa è un regista che si potrebbe definire
minimalista. Nei suoi spettacoli non c'è mai "troppo" e spesso tende a quel
carattere basico ed essenziale che vuole concentrare l'attenzione su un
personaggio o un gesto. In questa Maria Stuarda la semplicità
regna protagonista, in un allestimento che prevede una scenografia e
un'attrezzeria quasi assenti, ma mai si percepisce un vuoto o una mancanza.
I solisti, molto ben vestiti da Ursula Patzak, compiono una
serie di sguardi, gesti, movimenti che rapiscono, in perfetta armonia musicale
con la partitura.
Le scene di Sergio Tramonti, seppur minimal, ci sono e sono
molto efficaci e funzionali nel raccontare la prigionia di Maria che si
evolve verso il patibolo. Ottime le luci suggestive di Pasquale Mari.
Eccellente la direzione di Paolo Arrivabeni, che pare avere
trovato il punto giusto nell'interpretazione di questo Donizetti. I suoni
precisi, puliti e mai sovrastanti evidenziano i caratteri melodici del belcanto,
senza rallentare troppo nei passaggi patetici, ma lasciando spazio ai fraseggi e
ai colori, in un evidente dialogo continuo col palcoscenico. Al direttore va
riconosciuto anche il pregio di avere optato per una versione integrale con
tutti i da capo, approfittando di belle e interessanti variazioni.
Ottimo il Coro dell'Opera di Roma preparato da
Roberto Gabbiani.
La giovane Roberta Mantegna, allieva della Fabbrica
dell'Opera, mostra una vocalità davvero interessante, rotonda nella sua
leggerezza, con quel poco di acidulo che la rende ancor più accattivante e le
dona carattere. La linea di canto della sua Maria è piacevolmente
omogenea e sa prodursi in sfumature, trillini e volatine che dimostrano buona
preparazione. Peccato per la totale assenza di sovracuti e per la mancanza di
pathos nella bellissima preghiera di terzo atto, pagina di inarrivabile
splendore.
Buona anche la prova di Carmela Remigio nei panni di
Elisabetta anche se, non per la prima volta, si riscontrano certe
difficoltà quando il soprano interpreta ruoli così drammatici - nella tessitura
oltreché nell'accento - andando a cercare suoni che non le appartengono
naturalmente e che poi rischiano di renderla afona. La performance è comunque
positiva, soprattutto sotto il profilo dell'interpretazione del personaggio.
Sarebbe molto interessante ascoltarla in una esecuzione filologica della parte
di Maria.
Paolo Fanale è un Leicester incantevole. Il suo
gusto classico trova un compimento finissimo nel belcanto italiano, anche in
questo ruolo al limite del possibile, scritto per tenorino di grazia e che
presumibilmente all'epoca della composizione era cantato diversamente. Oggi, col
raddoppio dell'orchestra e una certa tradizione lirica alle spalle, cantare una
lunga serie di duetti e ariette con una tessitura che si muove continuamente tra
la zona delicata del passaggio e gli acuti, tra fa diesis e la, con punte al si
bemolle, do e re naturale, non è certo un compito facile.
Diversi grandi artisti, più o meno recentemente o nel passato, hanno avuto
problemi con questa parte, oppure hanno addirittura rinunciato. Fanale la prende
per il verso giusto, cantando con classe, senza mai forzare, restando sempre
naturale ed omogeneo, con una linea di canto morbida che arriva facilmente ai
numerosissimi sovracuti, tutti intonatissimi, senza lasciare intravedere alcuna
tensione vocale.
Il saper amalgamare la dolcezza con l'eroicità esprime indubbiamente un
valore aggiunto al suo fraseggio.
Ottimo il Cecil di Alessandro Luongo, abbastanza
efficace il Talbot di Carlo Cigni, ben centrata
l'Anna di Valentina Varriale, anch'essa allieva della
Fabbrica.
|