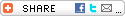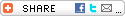Molti teatri d'opera italiani sono in gravi difficoltà, soprattutto per la
scarsità di risorse private e pubbliche a loro disposizione, ma – a parere dei
liberi professionisti che frequentano palcoscenici, quinte, uffici, corridoi e
magazzini – più presumibilmente per la malagestione, per l'eccessivo spreco di
risorse, per la mancanza di voglia di fare bene il proprio mestiere, o di
approfittare della propria posizione.
Come sempre accade nelle più tradizionali storie italiane, è che queste voci
circolano di bocca in bocca, ma mai nessuno denuncia il fatto o prende
provvedimenti.
Un imprenditore, che a causa della crisi si è trovato costretto a chiudere la
propria azienda, ha raccontato in un bar di avere ricevuto l'incarico di
facchino, come libero professionista, di una ben nota fondazione teatrale sotto
commissariamento, scoprendo che i compiti che svolge potrebbero essere assolti
dal personale interno che spesso si trova a fare nulla, ma che si cela dietro il
proprio ruolo, adducendo di non essere uno scaricatore.
La vera follia sta soprattutto nella mente chiaramente ottusa di queste
persone, che non riescono a vedere quanto la loro incuranza causa danno a chi
gli procura uno stipendio, col serio rischio di chiudere. Ma se davvero tutto
ciò accade così di frequente, in una logica di privatizzazione, forse sarebbe
meglio avere strutture aziendali più leggere affidandosi di volta in volta alla
libera professione, come si fa per gli artisti solisti.
Il Carlo Felice di Genova non è certamente esente da questo
genere di polemiche. Addirittura una piccola parte di dipendenti è scesa in
sciopero durante le prime tre recite di Carmen, obbligando la
maggior parte dei colleghi non aderenti a non poter svolgere il loro lavoro.
Sacrosanto è il diritto a protestare e scioperare; ma meschino e soprattutto
antiproduttivo è spingere altri con la forza. Così il teatro, non avendo potuto
aprire al pubblico, ha dovuto rimborsare i biglietti venduti, con una perdita
economica considerevole, che non dovrebbe finire per pesare – come sempre –
sulle tasche dei cittadini che pagano le passe, bensì direttamente sul
portafogli dei colpevoli.
In questo clima genovese che si potrebbe definire caldo, ma è forse più
opportuno definirlo desolante, la prova degli interpreti in palcoscenico, molto
probabilmente, è resa con minore intensità, minor vigore e minor passione a
causa di queste terribili giornate di sciopero che li ha condotti ad eseguire la
loro prima e unica recita di fronte ad una platea di studenti, certamente
entusiasti, ma chiassosi e non propriamente invoglianti.
È doveroso, importante e assolutamente fondamentale istruire i giovani in
merito all'arte dell'opera, ma è presumibilmente più semplice, per un cantante e
un musicista, farlo nel giusto ambito, cioè come avrebbe dovuto essere se gli
spettacoli precedenti non fossero stati annullati.
Così Sonia Ganassi, già Carmen
applauditissima in molti teatri, qui pare chiaramente sottotono.
L'interpretazione è discreta, ma la voce sembra essere quasi svuotata e
stimbrata, come se cantasse durante una prova.
Francesco Meli debutta il ruolo di Don José
in un'atmosfera che non è molto consona, con l'aggiunta del dispiacere che si
tratta del teatro della sua città. Come già scritto in molte occasioni, Meli è
uno dei migliori tenori del momento ed eccelle nel primo duetto, dove la sua
consueta raffinatezza riesce a dipingere un personaggio romanticissimo, pur
eccedendo un poco nell'emissione delle mezze voci: sono un suo segno distintivo
e le esegue con una perfezione ineguagliabile, ma in questa parte tende a
inserirne un po' troppe. E così le altre pagine dell'opera sono rese con più
eleganza che passione, col risultato di trasmettere emozioni poco filologiche.
Non è certo un delitto, ma è una questione di stile.
Serena Gamberoni non solo è la brava cantante degli ultimi
tempi, ma addirittura è ancora in miglioramento. Purtroppo la sua Micaëla,
soprattutto per l'orchestrazione che la sostiene, avrebbe bisogno di maggior
spessore vocale, non in termini drammatici, ma in pienezza e rotondità di suoni.
Sinceramente eccellente è il toreador di Alexander Vinogradov.
Finalmente è stato possibile ascoltare un Escamillo in grado di
accontentare il pubblico con gli acuti, saldi e ben sostenuti, così come vuole
la tradizione, ma anche pieno, solido e ben appoggiato nelle note basse, con
l'ulteriore impreziosimento di un buon fraseggio.
La rosa dei comprimari è perlopiù deludente, soprattutto il Moralès
di Claudio Ottino, lo Zuniga di Davide Mura
e la Frasquita di Francesca Tassinari, mentre
passano abbastanza inosservati la Mercédès di Margherita
Rotondi, le Dancaïre di Roberto Maietta e il
Remendado di Manuel Pierattelli.
Andrea Battistoni dirige l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice in maniera piatta e priva di colori, senza un minimo di
fraseggio.
Positiva la prova del coro diretto da Pablo Assante, mentre
insufficiente quella del coro voci bianche guidato da Gino Tanasini, impreciso,
poco intonato e rumoroso.
Lo spettacolo di Davide Livermore, con costumi di
Gianluca Falaschi e movimenti mimici di Giovanni Di Cicco,
è riuscito solo a tratti. Il regista eccelle sempre nella gestualità dei
protagonisti e nella costruzione delle controscene, ma sceglie un'ambientazione
che – oltre a non essere originale – ha poco a che fare con Carmen. Se la
rivolta siciliana del XIII secolo si è perfettamente sposata con la
trasposizione contemporanea della lotta alla mafia nei Vespri verdiani, la
storia della zingara che desidera restare libera fino all'ultimo istante della
sua vita poco ha a che fare con la rivoluzione cubana. Pertanto molte scene
diventano una forzatura, soprattutto il quarto atto in cui Escamillo aizza la
folla, fino a fare sembrare la musica avulsa dalla scena. L'adattamento della
taverna di Lillas Pastia in attuale locale notturno è simpatica, ma le
coreografie sono troppo simili al quinto atto dei Vespri e all'Italiana
pesarese. Migliore è la ricostruzione rivoluzionaria che apre il terzo atto, ma
non si lega comunque nella chiave d'insieme.
|