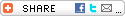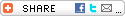Dopo tanti anni dalla sua ultima rappresentazione, non ci si aspettava che a Venezia fosse messa in scena con dei tagli. Non si auspicava certamente l'esecuzione delle pagine omesse prima della sua forma definitiva, ma almeno una versione integrale dello spartito di Fétis usato per il debutto, il 28 aprile 1865, dopo la morte di Meyerbeer.
Lo spettacolo di Leo Muscato presenta un impianto scenico pressoché identico a quello de I masnadieri di Parma: una grande pedana in pendenza, larga quasi quanto il boccascena, profonda dal proscenio al retropalco. Chiaramente non ricca e indubbiamente un grand-opéra dal basso impatto scenografico, ma un eccellente e minuzioso lavoro di regia fatto su ciascuno degli interpreti, dai protagonisti ai comprimari, dai coristi ai mimi e figuranti. Ognuno ha un'azione da compiere, un gesto da produrre, uno sguardo con cui trasmettere un'emozione o un'intenzione. Ed è così che Muscato dimostra di saper fare molto bene il suo mestiere, poiché tutto ha un senso, anche in ciò che succede dietro o accanto alle scene solistiche, per tutta la durata dei cinque atti della vicenda.
L'abilità scenografica di Massimo Checchetto si fa notare nella grandeur del terzo atto, in cui la poppa di una nave tardo quattrocentesca riempie letteralmente il palcoscenico. Bellissima è la tempesta finale, in cui l'ondulare, il cadere e il rialzarsi degli interpreti – col giusto ritmo – lascia davvero intendere ai bruschi movimenti del bastimento in balia del tifone. Le altre parti dell'opera sono quasi totalmente prive di scene, dotate di poca necessaria attrezzeria, ma comunque di grande effetto evocativo, poiché mai nulla sembra mancare.
Completano la riuscita dello spettacolo i bei costumi di Carlos Tieppo, giustamente misurati, mai troppo sfarzosi, ma con ogni dettaglio necessario a caratterizzare i personaggi. Lo stesso vale per le luci di Alessandro Verazzi, suggestive e abili nel dare risalto all'azione, coprendo il gap – voluto – della scarna scenografia, a favore di una visione più introspettiva. Forse sono un po' troppo colorate durante il consiglio, poiché fanno a pugni col pavimento rosso, ma ciò è immediatamente perdonato al finale primo, di sicuro effetto nel momento in cui si tinge di sangue all'anatema scagliato dal grande inquisitore.
Meno apprezzate sono le proiezioni d'entr'acte di Fabio Massimo Iaquone e Luca Attilii, poiché poco comprensibili. Forse il senso è quello di portare l'attenzione, come già fecero Scribe e Meyerbeer, sulla continua prevaricazione di alcuni popoli su altri, ma allora sarebbe stato il caso di ambientare L'africaine in un'epoca più contemporanea. Lasciandola ancorata al tempo di Vasco de Gama ha poco senso toccare altri e più recenti tasti dolenti della storia umana. Opportunamente adeguati anche i movimenti coreografici del choeur dansé nel finale quarto.
Sul fronte musicale Emmanuel Villaume porta alla Fenice un'orchestrazione molto elegante, un po' lontana dagli effetti tragico grandiosi meyerbeeriani, ma sicuramente rispettosa delle voci e del gusto romantico ottocentesco; venendo meno l'esecuzione integrale, come pure un'edizione critica, anche certe libertà nella concertazione e nell'andamento musicale possono essere accettate di buon grado. Senza dubbio il ritmo, il colore e l'accento occupano una parte importante del lavoro del direttore, anche se l'orchestra non lo segue fin da subito: non tutti i suoni del brano di apertura sono propriamente precisi. Più che positiva, anche se non eccelsa, la riuscita della difficile pagina del consiglio “Aux voix! Aux voix!”, vero arduo banco di prova.
Veronica Simeoni veste i panni di una raffinatissima Sélika, donna regale d'altri tempi e d'altre culture, più dolce che autoritaria nell'atteggiamento e nella vocalità. La parte, prima pensata per un mezzosoprano, poi per un soprano drammatico, è indubbiamente di grande difficoltà, ma l'intelligenza professionale della Simeoni le permette di eseguirla senza errori né sbavature, usando la sola ricetta – che sarebbe utile a molte delle sue colleghe – di cantare con la propria voce e la propria conoscenza tecnica, senza forzare, ne scimmiottare altri interpreti che, nel bene e nel male, possiedono altri strumenti. Così Veronica Simeoni risulta essere sempre lineare e morbidissima, omogenea su tutta la linea di canto, con una certa eleganza belcantista alla francese, rotonda e pulita negli acuti e naturalissima nelle note basse, per cui mai – se non forse in una frase verso il finale – predilige l'emissione di petto.
La affianca il Vasco de Gama di Gregory Kunde che, dall'alto della sua lunga esperienza, sa amalgamare l'accento eroico con quello patetico, riuscendo in un lirismo che lo vede vincitore, prima di tutto nei lunghi concertati, fino alla gran scena del quarto atto, in cui sa esprimere estasi nel cantabile e disperazione nella cabaletta. Il canto è spinto, ma mai forzato, i cromatismi forse non sono così ricercati, ma a favore di una particolare attenzione alla vocalità, ben timbrata, bilanciata e posizionata in avanti, che fa emozionare più volte il pubblico – che lo vorrebbe applaudire a scena aperta – soprattutto durante i limpidi e imperiosi acuti.
Angelo Veccia è centratissimo nei panni di Nélusko e si denota una puntuale ricerca dei caratteri drammatici e psicologici affidati a questo difficile personaggio, padre di molti ruoli del repertorio dell'opéra-lyrique. La voce è calda e brillante, ma gran parte del suono sembra fermarglisi in bocca invece di uscire e correre per la sala, pertanto risulta vincente negli ariosi e nei cantabili, in cui dà sfogo al suo bel timbro baritonale, mentre il recitativo, le parti più delicate compresi i piani e le pagine più drammatiche non riescono con altrettanta efficacia. Buono è l'uso degli accenti in termini di espressività, ma la dizione è pessima.
Jessica Pratt porta le vesta di un'ingiustamente decapitata Inès. Le pagine più importanti del ruolo stanno all'apertura di primo e quinto atto, ma quest'ultima scena, come già accennato, è stata purtroppo tagliata. Come sua consuetudine l'artista porta in palcoscenico una raffinatezza innata, che qui si nota particolarmente nel legato, nei filati e nell'omogeneità della linea di canto. Sfortunatamente i sovracuti non sono propriamente puliti, ma ci si augura si tratti di un problema passeggero.
Luca Dall'Amico è un Don Pédro squillante, luminoso e ben proiettato, che sa farsi notare tanto nelle scene d'assieme, quanto nel duetto di terzo atto, interpretando un personaggio che però è più vicino al rivale in amore che non al presidente del consiglio del re.
Emanuele Giannino e Mattia Denti sono un Don Alvar e un grande inquisitore particolarmente efficaci, mentre Davide Ruberti è un Don Diégo dalla voce un po' opaca. Rubén Amoretti è un gran sacerdote possente, ben timbrato e molto musicale, mentre Anna Bordignon forse si trova a dover eseguire una parte che non è la sua.
Molto buona, sia in termini musicali e vocali, sia interpretativi, la prova del Coro del Teatro la Fenice diretto da Claudio Marino Moretti, compresi i solisti a cui sono affidati i piccoli ruoli comprimari.
Successo meritatissimo per tutti, soprattutto per il teatro e la città, che sono chiamati a meditare: durante lo spettacolo erano presenti moltissimi turisti stranieri, arrivati a Venezia con lo scopo primario di assistere ad un titolo importante, pressoché mai rappresentato, contribuendo economicamente all'indotto in termini di notti in hotel, pasti ai ristoranti e acquisti nelle attività commerciali. È vero che il bilancio della Fenice raggiunge più facilmente il pareggio con la vendita dei biglietti degli eterni presenti Traviata, Barbiere e Don Giovanni, ma la città guadagna di più con la presenza di migliaia di viaggiatori giornalieri muniti di pranzo al sacco, o con qualche vero turista in meno, ma fruitore di ben più servizi? Questo è un invito a Venezia – e non solo – ad iniziare a misurare economicamente l'indotto portato dalla cultura, smettendo di vederla come un costo, ma iniziando a considerarla una vera risorsa e un vero motore per il Paese.
Â
|